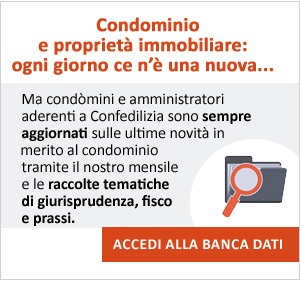Il disegno di legge di bilancio contiene – per quanto più direttamente ci riguarda – una disposizione parzialmente confortante e un paio di sorprese negative.
La norma almeno in parte positiva è quella che impedisce la prevista diminuzione delle detrazioni fiscali per interventi edilizi al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili, mantenendo invece – rispettivamente – le misure del 50% e del 36%.
Perché diciamo che la notizia è buona solo in parte? Perché verifichiamo come non ci si convinca ancora a procedere a un generale riordino degli incentivi in questione, stabilendo priorità – ad esempio, i lavori di miglioramento sismico, di efficientamento energetico e di eliminazione delle barriere architettoniche – e concentrando le risorse su di esse, altresì senza penalizzare così fortemente tutto ciò che non è “prima casa”.
La prima sorpresa negativa è l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. Non si era avuto sentore di questo ennesimo intervento normativo sul fenomeno, men che meno di un ulteriore incremento della relativa tassazione, in questo caso mirato sulla prima casa data in locazione (per le altre, l’aumento era stato stabilito già con la manovra per il 2024). In ogni caso, si tratta di una scelta sbagliata.
Se la finalità del Governo è quella di favorire le locazioni di lunga durata rispetto a quelle brevi, la strada giusta non è punire le seconde, bensì incentivare le prime. Si potrebbe, ad esempio, almeno dimezzare l’Imu per gli immobili locati a canone concordato (l’onere, nell’ambito di una manovra da 18 miliardi, sarebbe di una settantina di milioni) e applicare in tutti i comuni la cedolare del 10% prevista sempre per gli affitti a canone concordato.
L’altra sorpresa negativa è una norma nascosta tra le pieghe di un testo corposissimo. La riportiamo testualmente, per poi provare a spiegarne la finalità: “L’atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare, cui consegue l’acquisto a titolo originario in capo allo Stato ai sensi dell’articolo 827 del codice civile, è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica”.
Come nasce, questa disposizione? Come abbiamo spiegato nel numero di settembre, oltre dieci anni fa la Confedilizia iniziò a segnalare il fenomeno – fino a poco tempo prima impensabile – della rinuncia alla proprietà immobiliare. Ma il paradosso era che in Italia risultava difficile persino liberarsi di una proprietà, per una serie di ragioni giuridiche. Sennonché nell’agosto sono arrivate ad occuparsi della questione addirittura le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, districando la matassa e finalmente (si fa per dire) consentendo ai proprietari di disfarsi degli immobili diventati un peso.
Ora una manina del Leviatano ha inserito nel disegno di legge di bilancio un comma il cui scopo, in sostanza, è vanificare la sentenza della Cassazione e di fatto impedire – considerate le diaboliche richieste di conformità varie, impossibili da ottenere – che i privati possano rinunciare alla proprietà di immobili che non riescono più a mantenere e su cui devono anche pagare ogni anno una patrimoniale denominata Imu (che la manina del Leviatano si guarda bene dal sopprimere).
Ora tocca al Parlamento. Vedremo gli sviluppi di tutte queste vicende.
Giorgio Spaziani Testa
da Confedilizia notizie, novembre ’25
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.